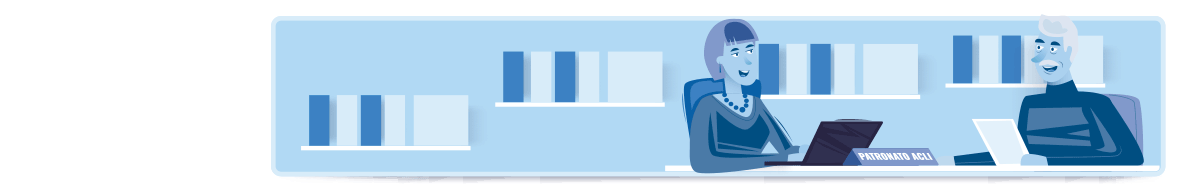A cura di Daniele Rocchetti, delegato nazionale alla Vita Cristiana
don Carlo Carlevaris (16 aprile 1926-2 luglio 2018)
Nei giorni scorsi a Torino, nella Piccola Casa del Cottolengo, è morto don Carlo Carlevaris. Aveva 92 anni ed è stato uno dei primi preti operai italiani.
Chi è don Carlo Carlevaris
Assunto alla Lamet, azienda della cintura torinese, lavorò poi in Fiat, alla Grandi Motori, alla Lancia e alla Michelin. Una scelta la sua, come quella di centinaia di altri negli anni sessanta e settanta, per proporre un nuovo modo di essere prete e per ridare dignità al lavoro, anche e soprattutto del lavoro manuale. Un’esperienza – fatta di Vangelo e di fedeltà all’uomo, di radicalità sotto il segno della condivisione (“essere come loro”) e della povertà – che oggi andrebbe ripresa e studiata con più attenzione.
Don Carlo ebbe poi la ventura di incontrare sul suo cammino uno dei più significativi vescovi del post Concilio in Italia: “padre” Michele Pellegrino, un uomo colto, un raffinato studioso di Patristica, un testimone coerente autentico del Vangelo, un vescovo che credeva alla libertà e alla possibilità di una corresponsabilità ecclesiale, a un autentico “camminare insieme” (titolo della lettera pastorale pubblicata l’8 dicembre del 1971 nata da una lunga e articolata consultazione della pluriforme comunità cristiana torinese di quegli anni). Don Carlo collaborò a lungo con Pellegrino aiutando prima nella scrittura e redazione del testo e poi cercando di tradurre nelle pratiche pastorali le tre parole fondamentali della lettera pastorale: povertà, libertà e fraternità. Battendosi per una chiesa che, fedele a Gesù di Nazareth, fosse capace per davvero di fare la “scelta preferenziale per il poveri”.
“No ho consigli da dare”
Alcuni anni fa, nella mansarda di via Belfiore, nel quartiere di San Salvario a Torino mi è capitato di incontrarlo per un’intervista. Questo è il resoconto. Un omaggio ad un credente che in un articolo pubblicato sul settimanale torinese La Voce del Popolo nel 2007, così tentava un bilancio dei suoi, allora, ottant’anni: “Non ho consigli da dare. Cerco ancora di imparare a vivere questa stagione, l’ultima della vita, in fedeltà alla scelta iniziale: stare tra la gente, lottare con chi lotta, difendere e servire i poveri. A dirla tutta sono contento di vivere questi ultimi anni nella soffitta di San Salvario con i neri, i musulmani e le prostitute all’angolo che mi salutano con un sorriso. C’è ancora qualcosa da fare. Auguro a tutti la scoperta dei poveri, dei deboli, degli ultimi”.
Scena di tanti anni fa. La Fiat decide di licenziare 500 operai comunisti
“La vedo ancora adesso quella scena. Sono le cinque di un mattino di settembre. Io sono il cappellano della fabbrica, Fiat Grandi Motori, poco più che trentenne. L’azienda ha deciso di licenziare gli operai comunisti. ‘Dobbiamo eliminarli per avere le commesse americane. Produciamo i motori delle navi e gli Stati Uniti sono un mercato importante’, avevano spiegato i capi prima delle ferie. Il sistema era stato semplice: con la chiusura estiva si rinnovavano i tesserini di ingresso. Chi li avesse ricevuti a casa durante le vacanze sarebbe tornato al lavoro. Gli altri erano automaticamente licenziati. E adesso io sono lì a dover scegliere. Davanti al cancello c’è una massa di persone che entrano, spinte dalla necessità del salario. Hanno gli occhi bassi, si vergognano di guardare in faccia i loro compagni senza tessera. Si vergognano di dover lavorare. Sul marciapiede restano in cinquecento licenziati su duemilacinquecento. Io devo decidere: entro o resto sul marciapiede con quelli che protestano? Decido di restare. Da quale parte deve schierarsi un prete se non con gli ultimi?”. A parlare così è don Carlo Carlevaris, primo prete operaio nella Torino degli anni Sessanta.
Don Carlo, da dove nasce questa scelta?
Amo ripetere che la Chiesa dei poveri non era ieri, perché la Chiesa di ieri assisteva i poveri: san Vincenzo, orfanotrofi, uffici di assistenza delle parrocchie. Se sono prete lo devo al Cottolengo. La mia famiglia era povera e non potevano farmi studiare. Qualcuno mi ha indicato il Cottolengo, un luogo dove si poteva diventare prete senza pagare. La Chiesa era, fino a qualche anno fa, e per certi versi lo è ancora oggi, essenzialmente la volevamo anche noi e l’han voluta tanti prima di noi, la Chiesa dei poveri, che assisteva i poveri, che aiutava i poveri, che veniva incontro alla povera gente. Con gli anni abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo cercato in qualche modo di teorizzare questa Chiesa chiamandola “Chiesa dei poveri”, o “Chiesa povera”. Noi – preti operai – in qualche modo ci siamo messi in questo filone per trasformare la Chiesa in una Chiesa dei poveri: molti sono andati in missione, altri hanno fatto delle opere sociali di vario tipo. Noi abbiamo pensato di far vivere un’immagine di Chiesa che fosse non una Chiesa dei poveri ma una Chiesa povera. Ci siamo in qualche modo identificati con l’anello debole di questa società che non erano i miserabili ma i lavoratori e ci siamo sentiti in affinità ad essi, credendo in questo modo di portare un contributo alla Chiesa, portando alla Chiesa i poveri di quel momento. Ci siamo messi non tanto a servizio, ma in compagnia. In fondo non sono andato in fabbrica perché gli operai fossero una classe ma perché erano i poveri. Mi dava fastidio l’idea che un prete potesse vivere con loro. Pensavo, e penso ancora oggi, che un sacerdote debba vivere come loro.
Cosa hai fatto?
Ho scelto di diventare ufficialmente Carlo e cercarmi un’occupazione spulciando gli annunci sul giornale. Sono finito alla Lamet, un’azienda dell’indotto Fiat proprio di fronte a Mirafiori. All’inizio nessuno dei miei compagni sapeva che ero prete. Un giorno organizzammo uno sciopero, il primo che si svolgeva in quella fabbrica dove si lavorava con turni di dodici ore. Un pomeriggio arrivò un mio collega: “Il padrone ce l’ha proprio con te. Va dicendo in giro che sei un prete. È chiaro che lo fa per screditarti”. Prete e operaio, due figure antitetiche quarant’anni fa, due figure che rischiano oggi la marginalità. Allora il prete che entrava in fabbrica era considerato uno che attraversava le linee nemiche. C’era un muro. Gli operai erano in gran parte comunisti e i cattolici erano per definizione democristiani. Un giorno una giovane operaia mi fermò: “Carlo, voi preti ci avete costretto a scegliere tra Cristo e i nostri compagni di lavoro”. Io sapevo che non era così.
Non sarà stato facile…
No, mi dicevano: ‘perché vai nella fabbrica? Non sarebbe meglio che svolgessi regolarmente il tuo mestiere di prete? Ci sono tante cose da fare in parrocchia’. Non era stato facile evangelizzare la fabbrica. Ero diventato cappellano del lavoro alla Fiat quasi per caso. In breve tempo avevo capito che quel ruolo era ambiguo. Gli operai mi consideravano una spia del padrone, i capi cercavano di strumentalizzarci per contrastare i comunisti. Ricordo un pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall’azienda nel 1958. Alla processione che raggiungeva la grotta c’erano tremila operai in tuta bianca che sventolavano grandi bandiere della Fiat. Dietro gli stendardi, in prima fila, c’erano Valletta e Agnelli. Così pensavano di cristianizzare la fabbrica. Al ritorno denunciai quelle ambiguità. Arrivò il diluvio. La Fiat chiese al vescovo il mio allontanamento. Il cardinale dell’epoca, Maurilio Fossati, mi tolse l’incarico che avevo nell’Azione Cattolica. E il prefetto del Sant’Uffizio, il cardinale Alfredo Ottaviani, mi scrisse una lettera per chiedere “la verifica del tuo insegnamento” e accusarmi di “deviazione ed eterodossia”.
In Italia, i preti operai, negli anni Settanta, erano trecento. Il primo di loro, nel 1950, fu don Bruno Borghi, amico carissimo di don Lorenzo Milani, il secondo, don Sirio Politi, di Viareggio. Ora sono poche decine, sparsi qua e là: alcuni in fabbrica, altri nei cantieri o nelle cooperative sociali. Sempre ai bordi. Sempre a raccontare che Dio ama la periferia.
Poi a Torino è venuto padre Pellegrino…
Sì, prima di essere nominato vescovo era docente di Letteratura Cristiana antica. Nel suo stemma mise il motto “Evangelizare pauperibus”, evangelizzare i poveri. Pellegrino era diventato vescovo nel 1965. La sua lettera pastorale Camminare insieme – scritta nel dicembre del 1971 sulla base dei documenti preparatori dei laici della diocesi, a partire da un testo che avevo proposto io – rappresentò una svolta per gli operai della città. Si parlava di «scelta di classe a favore dei più poveri » e si considerava «un dovere la solidarietà tra i lavoratori» perché «sarebbe egoismo riprovevole, quando la lotta appare come l’unico mezzo per la difesa dei propri diritti, mancare di solidarietà con i propri compagni solo allo scopo di evitare noie». Una rivoluzione copernicana. Solo tre anni prima il vicario di Roma, Angelo Dell’Acqua, aveva scritto a un mio amico, il sindacalista della Cisl torinese Mario Gheddo: «La Chiesa, mio buon Gheddo, non vuole la lotta di classe ma una fattiva collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori». La Camminare insieme aveva scosso la città della Fiat. Aveva fatto scalpore la scelta di Pellegrino di incontrare gli operai ai giardini di Porta Nuova, al presidio dei metalmeccanici in lotta per il contratto. Gesti che avevano irritato i credenti più tradizionalisti. Sul settimanale cattolico Il Nostro Tempo l’intervistatore aveva chiesto al cardinale: «Lei ha detto che non ci sono padroni: non è questo un incitamento alla rivolta, all’anarchia?». La scelta di classe aveva puntato i riflettori della Chiesa sul mondo della fabbrica e aveva messo in subbuglio il resto della società: era la protesta delle novantanove pecore del gregge contro le attenzioni riservate a quella che si credeva smarrita.
Ora come vivi?
Lo vedi. abito in soffitta e al pian terreno stanno le Piccole Sorelle di Gesù. Non mi occupo più di problemi politici e sindacali, ma insieme a loro in un quartiere disgraziato mi occupo di prostitute, di magnacci, di ladri. Sono coinvolto da loro in queste storie facendo certe scelte. Mi trovo a dover affrontare delle situazioni con delle persone concrete a cui le istituzioni danno delle soluzioni che il più delle volte non rispondono a dei bisogni. Quando ero al Cottolengo facevo un po’ di scuola e assistevo 92 bambini, metà dei quali erano degli ex-esposti, abbandonati. Quando arrivava giugno, dormivano tutti nello stesso dormitorio, si domandavano “Ma io dove vado?”. Li sentivo piangere durante la notte e quindi mi avvicinavo al loro letto, essi piangendo ripetevano la stessa frase: “Ma io dove vado?“. Nessuno era mai venuto a trovarli e non sapeva chi c’era al di là del muro. La soluzione era quella di passare al di là del muro . Situazioni del genere mi hanno aiutato a rendermi conto dei problemi della gente, del come io do a questa gente la sensazione di essere un uomo che soffre con loro, che cerca con loro la soluzione. Non gli dico: “Guai a te se fai quella cosa”, gli dico: “Vediamo un po’ insieme qual è la soluzione migliore per te”. Le istituzioni pubbliche come la Chiesa e i partiti hanno progetti e fatto elaborazioni su un popolo che non esiste più. Spesso non sanno dare risposte adeguate perché non sempre capiscono e non sono vicine ai problemi reali che la gente vive.
Non credi di cadere nella trappola e nella tentazione della nostalgia?
Il mondo è molto cambiato. Gli operai sono meno numerosi di un tempo e la povertà non va di moda. Chi è povero cerca di nascondere l’indigenza come la cenere sotto il tappeto piuttosto che rivendicare diritti. Le poche energie che possono spendere i preti vanno, giustamente, a favore degli immigrati stranieri. Non è solo un problema di sacerdoti disponibili. Mi pare di capire che c’è stato anche un cambio di rotta nella Chiesa italiana. Negli ultimi anni in Italia si sono privilegiati gli aspetti legati alla spiritualità e al culto piuttosto che la testimonianza tra i più deboli. I giovani seminaristi si sono sentiti più attratti dai ragazzi dei papa-boys che dalla vita delle tute blu. Anche questo è un segno dei tempi.