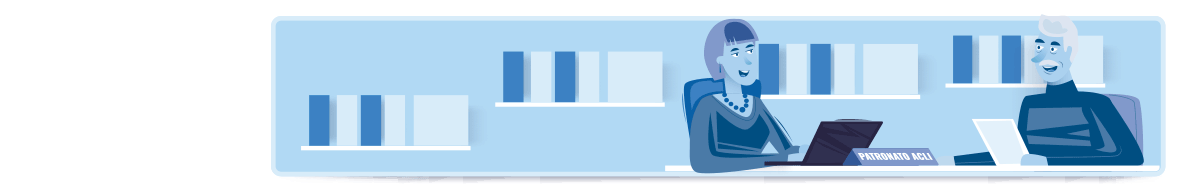I giovani e il lavoro che cambia sono stati al centro dell’ultimo Incontro nazionale di studi delle Acli, che si è svolto a metà settembre a Napoli. Un tema importante, che rischiamo di non capire appieno perché poco attenti alle trasformazioni della sfera lavorativa.
Nell’ultimo anno, oltre 23mila giovani hanno lasciato l’Italia. Non tutti sono “cervelli”, ma ragazzi qualunque in cerca di lavoro che vanno via da una realtà in cui lo sbocco più immediato è il cosiddetto “lavoretto”, spesso consegne o servizi a domicilio trovati attraverso una piattaforma digitale.
La cosiddetta gig economy, ossia l’economia dei lavoretti online, ha però dato vita a un mercato del lavoro che produce numeri da settore “vero”: nel 2015, il numero di piattaforme digitali di lavoro online nel mondo ha raggiunto le 2.300 unità.
Nello stesso anno, tra queste piattaforme, Amt ha dichiarato 500.000 iscritti di 190 paesi diversi, Top Coder 753.911, Upwork 8 milioni da 180 nazioni, Freelancer 14,5 milioni con 7,5 milioni di progetti mentre Twago 263.715 iscritti con 66.683 progetti (si vedano gli studi di Pooler e di Strube).
L’Ufficio internazionale del lavoro (Ilo) nel 2016 ha svolto un’indagine che ha coinvolto 1.100 lavoratori di due piattaforme di lavoro online, analizzandone le condizioni di lavoro, i percorsi professionali e la situazione economica.
Il 40% degli intervistati ha indicato che il lavoro a chiamata rappresenta la fonte principale del proprio reddito. In generale, i lavoratori hanno manifestato insoddisfazione per i bassi compensi, per la scarsità di offerte di lavoro e per la mancata attenzione alle loro necessità.
Questo perché, da un punto di vista contrattuale, sono considerati soggetti autonomi. Di conseguenza, le piattaforme per le quali lavorano non devono assolvere obblighi di contribuzione previdenziale. Peraltro, si tratta di figure professionali che hanno difficoltà a aderire a organizzazioni sindacali e quindi a migliorare la propria condizione attraverso la contrattazione collettiva.
Da dove muovere per ripensare ed estendere anche a questi lavoratori adeguate tutele professionali? Dall’incontro di Napoli sono emerse alcune proposte che vanno in questa direzione.
Innanzitutto, dovrebbe essere garantita ai lavoratori della gig economy la possibilità di costituire rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro.
Occorrerebbe, inoltre, implementare meccanismi che possano garantire, anche a fronte di prestazioni occasionali e di una carriera lavorativa disarticolata, la possibilità di beneficiare di un trattamento pensionistico complementare.
Sarebbe poi importante garantire loro l’esercizio dei propri diritti (sciopero compreso), senza conseguenti comportamenti discriminatori e punitivi da parte del datore di lavoro.
Una possibile strada per garantire a queste figure professionali un’adeguata tutela potrebbe essere quella di estendere loro la disciplina in materia di somministrazione di lavoro, qualificando la piattaforma digitale quale agenzia di somministrazione e l’esercente che utilizza il servizio del lavoratore quale utilizzatore.
Tuttavia, vista la varietà di piattaforme esistenti (Uber, Deliveroo, Foodora, TaskRabbit, etc.), si tratta di una soluzione che potrà trovare applicazione solo in un numero circoscritto di ipotesi (in particolare le piattaforme che gestiscono la distribuzione di beni).
Questa soluzione è stata presa in seria considerazione dal Ministero del Lavoro e potrebbe diventare presto una proposta concreta da sottoporre alle parti sociali. Al momento è stata inserita nelle linee guida dell’Italia in vista del centenario dell’Ilo che cade nel 2019.